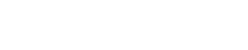Il D.Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico, porta al titolo due parole chiave: prima della parola “sicurezza”, vi è la parola “salute”.
Perché allora, per lo più, si sente parlare solo di sicurezza sul lavoro? Perché, quando i lavoratori sono chiamati a partecipare ai corsi di formazione, la comunicazione che passa è che devono svolgere i “corsi (solo) sulla sicurezza”? Perché non si sente mai parlare di salute? Oppure, perché pensiamo alla salute solo quando avviene qualcosa di spiacevole? O, ancora, perché quando si parla di salute, questa viene considerata solo nella sua dimensione “fisica”?
Una primissima considerazione da fare è che, all’interno del Testo Unico, c’è un richiamo alla definizione di “salute”, fornita nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
Nonostante più volte nel Decreto si rimandi all’integrità psicofisica dei lavoratori (tra gli obblighi del Medico Competente) e alla necessità di valutare tutti i rischi, tra cui quelli di natura psicosociale (tra gli obblighi del Datore di Lavoro), nella realtà dei fatti la considerazione e seguente valutazione della parte “psico” spesso passa in secondo piano, poiché la cosa più importante è che il lavoratore “non si faccia male”.
Ad esempio, pur considerando l’obbligatorietà della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (l’unico dei rischi psicosociali solitamente valutato, seppure si faccia riferimento anche a fenomeni quali mobbing e burnout), è lecito chiedersi se questa venga davvero presa in considerazione nella sua totalità: nonostante il manuale della metodologia Inail, fin dalle prime pagine, evidenzi come la valutazione, “al di là del mero rispetto degli obblighi della normativa, venga intrapresa quale opportunità di sviluppo e accrescimento del benessere e della produttività dell’azienda”, spesso si traduce in una veloce e poco approfondita analisi, che porta alla definizione di un rischio “non rilevante”.
Ma l’indagine così svolta porta ad avere una “fotografia” della percezione di stress da parte dei lavoratori? Si è consapevoli di quali conseguenze possa portare una inefficace valutazione e gestione di questo rischio “che non si vede”? Spesso non ci si rende conto che tra il rompersi un braccio per una disattenzione e un “esaurimento” dettato da continui ed eccessivi carichi lavorativi non ci sono differenze se la conseguenza è di non avere a disposizione il proprio lavoratore per un periodo di tempo più o meno lungo. E il lavoratore non è l’unico a subire delle conseguenze…
Una seconda considerazione (strettamente legata alla prima) ha a che vedere con quanto studiato da una branca della Psicologia, denominata Psicologia della Salute, secondo la quale culturalmente siamo portati a comportarci seguendo non un “modello salute”, ma un “modello malattia”: si parte dall’individuazione delle varie forme del malessere, passando per l’individuazione delle varie cause e dei vari meccanismi che lo alimentano, fino all’identificazione conseguente delle varie metodologie per rimuoverlo o prevenirlo. In breve: pensiamo alla nostra salute solo quando ci succede qualcosa.
Secondo questo modello sembrerebbe quasi che la salute sia un dato per scontato, non solo dai lavoratori, ma anche dai datori di lavoro. Negli ultimi anni, infatti, è aumentata la richiesta produttiva del mercato, cosa che ha spinto gli imprenditori a spingere maggiormente sulle proprie risorse umane: qualcuno di questi si è mai chiesto quali potrebbero essere le conseguenze psicofisiche sui propri lavoratori quando le richieste lavorative superano le loro risorse?
Sembrerebbe che la responsabilità di queste situazioni ricada solo su chi è in capo all’azienda, ma non è così: se si capovolge la medaglia e se ne analizza anche l’altra faccia, i lavoratori (così come i preposti) che responsabilità hanno di fronte alla loro salute? Sono dei soggetti passivi oppure possono essere anche loro degli attori attivi e promotori di una cultura della salute e della sicurezza?
Non è facile rispondere a tutte queste domande perché avventurarsi nella risposta potrebbe portare ad analizzare situazioni ben più profonde di quelle che si vedono, tali da essere difficili da sradicare.
Attualmente, il dato di realtà ci suggerisce come ci muoviamo ancora in un’ottica di protezione, seguendo un modello malattia in cui il concetto di salute viene considerato solo nella sua accezione “fisica”, mentre le dimensioni “mentale” (soprattutto) e “sociale” (meno nota) vengono ancora molto stigmatizzate.
Se c’è però una cosa che questa pandemia ci ha insegnato è che, pian piano, stiano prendendo piede anche queste dimensioni: cominciano ad essere tanti gli interventi che le aziende stanno mettendo in campo per preservare la psiche dei propri lavoratori in risposta agli eventi degli ultimi due anni, laddove rilevante è stato anche il fenomeno del distanziamento sociale.
La strada per il cambiamento è lunga, ma ognuno di noi può provare a riflettere e a sensibilizzare, muovendosi davvero in un’ottica di prevenzione, così come auspicato dal D.Lgs. 81/08, in cui tutti all’interno dell’organizzazione costruiscono la salute (in tutte le sue dimensioni) e la sicurezza giorno dopo giorno.
Cosa succederebbe se cominciassimo a non dare per scontato la nostra salute e scoprissimo che il nostro benessere potrebbe addirittura essere migliorato? Quali sarebbero i vantaggi sul posto di lavoro (e non solo) se scegliessimo di seguire un “modello salute”? Uno sguardo al modello islandese sulla settimana lavorativa di quattro giorni potrebbe insegnare qualcosa…
Pubblicato su Punto Sicuro